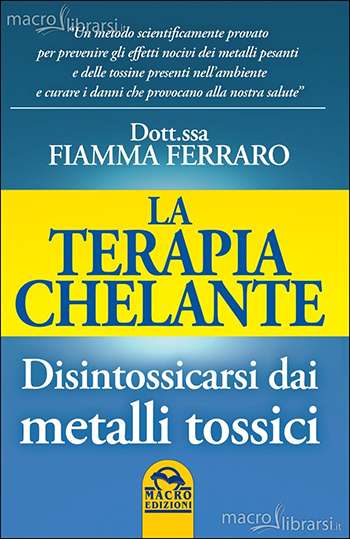- In:
- Posted By: Redazione
- Commenti: 0
Il Succo di barbabietola migliora le prestazioni sportive
 Migliorare naturalmene le proprie prestazioni fisiche nello sport è possibile? Certamente grazie alla barbabietola o rapa rossa, e in particolar modo al suo succo, un concentrato di nitrati estremamente preziosi per il nostro organismo e fondamentali per combattere la fatica, ma non solo perché essa possiede proprietà fondamentali anche contro l'anemia e durante la gravidanza anche per il suo apporto di acido folico.
Migliorare naturalmene le proprie prestazioni fisiche nello sport è possibile? Certamente grazie alla barbabietola o rapa rossa, e in particolar modo al suo succo, un concentrato di nitrati estremamente preziosi per il nostro organismo e fondamentali per combattere la fatica, ma non solo perché essa possiede proprietà fondamentali anche contro l'anemia e durante la gravidanza anche per il suo apporto di acido folico.
Le proprietà del succo di Barbabietola, un alleato indispensabile di ogni atleta e sportivo
Da molti anni oggetto di molte indagini e ricerche grazie al suo alto contenuto di vitamine, sali minerali, nitrati e antiossidanti, il succo di barbabietola è stato testato sul campo molte volte e non hai mai deluso gli sportivi che l'hanno assunto a livello agonistico prima di una gara.
Un esempio lampante è la ricerca della University of Exetere (UK) che dopo aver somministrato a diversi ciclisti professionisti mezzo litro di questo famoso succo prima di percorrere varie distanze hanno osservato un netto miglioramento nei tempi e un totale distacco rispetto di quasi 11 secondi nella breve distanza e di quasi 45 secondi su quelle più lunghe, rispetto a coloro che avevano assunto il succo “deprivato” di nitrati.

 Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali del nostro corpo. È conosciuto anche come “ormone dello stress”, proprio perché la sua produzione, in genere, aumenta a seguito di situazioni di forte stress, fisico e mentale, al fine di incrementare la quantità di energia necessaria al nostro corpo.
Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali del nostro corpo. È conosciuto anche come “ormone dello stress”, proprio perché la sua produzione, in genere, aumenta a seguito di situazioni di forte stress, fisico e mentale, al fine di incrementare la quantità di energia necessaria al nostro corpo.